Soprattutto al 5° anno di corso vengono analizzati numerosi processi biochimici e tra questi la fermentazione alcolica. E’ stato quindi naturale cercare di studiare, anche in laboratorio, questo importante processo metabolico, che ha grande importanza da millenni per l’uomo: basti pensare ai processi di produzione del vino e di tutte le bevande alcoliche. L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di riprodurre in laboratorio la fermentazione alcolica effettuata dal lievito Saccharomyces cerevisiae (il comune lievito di birra), studiandola da un punto di vista analitico e cinetico, cercando di misurare la variazione della concentrazione di substrato nel tempo per ricavare qualche parametro cinetico di questa reazione. Sono stati inizialmente approfonditi gli aspetti teorici relativi ai microganismi in grado di provocare fermentazioni (batteri e lieviti), quindi si è cercato di mettere a punto una procedura che riproducesse in modo abbastanza fedele il processo naturale di fermentazione (sono state provate alcune apparecchiature, variando le condizioni di lavoro). Infine, trovate le migliori condizioni, sono state fatte numerose prove, sottoponendo a fermentazione soluzioni di saccarosio puro al 15-16%, utilizzando del comune lievito di birra.
I dati, raccolti ed elaborati successivamente, hanno fornito i risultati riportati di seguito:
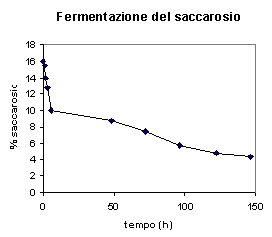 |
Curva
di crescita dei microrganismi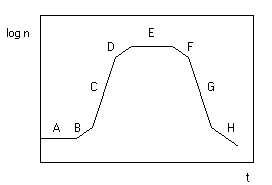 |
Come si vede i dati sperimentali del progressivo
consumo del saccarosio, che veniva determinato in tempi successivi mediante
rifrattometria, ben si adattano alla classica curva di crescita dei microrganismi, con le
sue varie fasi: latenza, incremento logaritmico, ecc.
Applicando ai dati sperimentali l'equazione di Michaelis-Menten linearizzata secondo
Lineweaver-Burk sono stati ottenuti alcuni dati cinetici relativi al processo di
fermentazione:
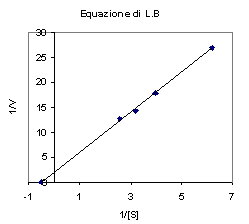 |
equazione di Michaelis-Menten
linearizzata secondo Lineweaver-Burk: Km
= 1,90 |
A conclusione del presente lavoro si può dire
che si è trattato senz’altro di un’esperienza interessante, che ha permesso di
verificare in laboratorio, sperimentalmente, alcune conoscenze apprese nelle lezioni
teoriche. Ha inoltre richiesto numerose prove per l’ottimizzazione delle condizioni
di lavoro ma alla fine ha prodotto risultati significativi, che hanno potuto trovare una
spiegazione logica e coerente con i meccanismi dei processi fermentativi. Ma la
simulazione della fermentazione alcolica è ancora suscettibile di ulteriori studi ed
analisi: infatti si potrebbe migliorare la composizione del brodo di coltura, utilizzare
un fermentatore più idoneo, studiare parallelamente alla diminuzione di saccarosio anche
l’aumento del grado alcolico (alcuni tentativi sono stati già fatti, prelevando
campioni e distillandoli, determinando il contenuto alcolico per via rifrattometrica ma i
risultati non sono stati significativi), analizzare con metodi più raffinati (ad esempio
gascromatografici) i campioni prelevati ad intervalli regolari, in modo da dosare non solo
l’alcol etilico ma tutti i composti volatilizzabili, ecc. Questi progetti erano già
stati presi in considerazione anche nel presente lavoro ma sono stati abbandonati per
mancanza di tempo o di attrezzature idonee; potranno tuttavia essere una stimolo prezioso
per tutti coloro che vorranno continuare in questa direzione, realizzando quei
collegamenti multidisciplinari che sono ormai al centro della moderna didattica nel campo
professionale e scientifico.
Bibliografia
R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro - "Analisi
chimica strumentale" - Zanichelli Bologna 1997
C. Quaglierini, M. Vannini, A. Paladino – "Chimica delle fermentazioni e
laboratorio" – Zanichelli Bologna
Per informazioni sulle procedure analitiche inviare una e-mail al prof. Claudio Casalino presso itisvc@itisvc.it